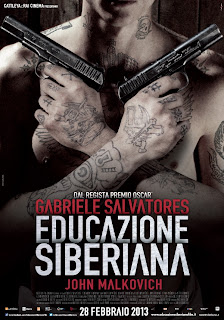Attraverso un rapido botta e risposta di lettere piene di pettegolezzi, spulciando nell'immaginaria corrispondenza dei personaggi, il lettore si trova immerso bruscamente nel pieno di un'intricata situazione sentimentale, che coinvolge diverse famiglie e fa versare fiumi di inchiostro e di veleno: Lady Susan, che ha sedotto l'affascinante ma coniugato Mr Manwaring, si insedia a casa della cognata, Mrs Vernon (che la odia, dal momento che proprio Lady Susan cercò con ogni mezzo, anni prima, di far desistere il cognato dal proposito di sposarla) e anche lì semina zizzania. Cerca di sedurre il fratello della cognata, Reginald De Courcy, ma contemporaneamente scrive all'amica Alicia: «Mia carissima amica, mi rallegro con te per l'arrivo di Mr De Courcy e ti consiglio senz'altro di sposarlo; è noto che i possedimenti di suo padre sono considerevoli e, ne sono certa, inalienabili.»
Ma Lady Susan non si occupa solo di civettare con ogni uomo che le capiti a tiro: si interessa anche dell'educazione della figlia adolescente, Frederica.
 «Non è che mi trovi d'accordo con la moda attuale di conseguire una perfetta conoscenza delle lingue, delle arti e delle scienze; è tempo sprecato: essere maestre di francese, di italiano, di tedesco, di musica, di canto, di disegno ecc., può concedere a una donna un certo plauso, ma non aggiungerà un solo amante alla sua lista. [...] Non pretendo, quindi, che l'istruzione di Frederica oltrepassi la superficialità e mi soddisfa l'idea che non rimarrà a scuola così a lungo da imparare qualcosa per intero. Spero piuttosto di vederla maritata a Sir James entro un anno.»
«Non è che mi trovi d'accordo con la moda attuale di conseguire una perfetta conoscenza delle lingue, delle arti e delle scienze; è tempo sprecato: essere maestre di francese, di italiano, di tedesco, di musica, di canto, di disegno ecc., può concedere a una donna un certo plauso, ma non aggiungerà un solo amante alla sua lista. [...] Non pretendo, quindi, che l'istruzione di Frederica oltrepassi la superficialità e mi soddisfa l'idea che non rimarrà a scuola così a lungo da imparare qualcosa per intero. Spero piuttosto di vederla maritata a Sir James entro un anno.»Altra questione che preme alla protagonista: imparentarsi con Sir James, un uomo che la stessa Lady Susan ha sedotto per allontanarlo dalla sorella del suo spasimante Manwaring, e adesso cerca di riciclare come marito per la giovane figlia che non vuole saperne nulla.
«Altre madri avrebbero insistito perché le loro figlie accettassero all'istante un partito così buono, ma io non mi sono sentita di imporre a Frederica un matrimonio contro il volere del suo cuore, e invece di adottare una misura così drastica, ho semplicemente fatto in modo di renderle la vita insopportabile, cosicché sia lei ad accettarlo di sua volontà. Ma adesso basta con questa fastidiosa ragazza.»
Il breve romanzo epistolare delinea una protagonista stupefacente: straordinariamente odiosa ma anche straordinariamente credibile. Jane Austen ritrae con chirurgica precisione uno spaccato del mondo borghese e provinciale a cavallo tra Settecento e Ottocento. Lasciandoci curiosare nella corrispondenza del suo serraglio di civette, vittime e pettegoli, ci introduce meravigliosamente in un ambiente alla moda e "perbene", ma che nasconde intimità e intenzioni ributtanti. I borghesi, i latifondisti, le donne in età da marito si mostrano in "Lady Susan" portatori di ogni vizio, ben celato sotto una coltre di raffinatezza e buone maniere: persone fedifraghe, false, subdole, opportuniste, intriganti, maldicenti e malpensanti, invidiose. Lady Susan, in particolare, è un personaggio imperdibile, forse il più odioso e spregevole di cui io abbia mai letto. Non solo donna impudica e fintamente irreprensibile (quel che si dice un'acqua cheta o, meglio ancora, una gattamorta), ma infida anche come cognata e parente; madre snaturata, egoista e noncurante, capace solo di disprezzare la figlia e di ritenerla perfino una rivale in amore (richiamando molto il paradigma di madre borghese sapientemente proposto, ad esempio ne "Il Ballo" da Irène Némirovsky). Ovviamente, anche nelle relazioni amorose Lady Susan si mostra disonesta, vendicativa e calcolatrice. Dopo aver battibeccato con Reginald e averla infine avuta vinta, scrive all'amica Alicia:
«Non posso perdonare una tale prova di orgoglio neanche di fronte alla sua attuale umiliazione, e non so decidermi se punirlo lasciandolo immediatamente dopo la nostra riconciliazione, oppure sposandolo e torturandolo per sempre.»
In questo libriccino arguto e pungente, Jane Austen ritrae senza scrupoli un ceto sociale a cui apparteneva ma che, forse, disprezzava intimamente. Con un atteggiamento che è stato definito "femminista ante litteram", documenta e in qualche modo ridicolizza la mentalità piccolo-borghese per cui conta solo accasarsi col partito migliore, tutelando il patrimonio e il buon nome della famiglia, anche quando le apparenze nascondono vizi e disonestà.
Temevo di trovare pesante la lettura di Jane Austen, ma non è stato affatto così. "Lady Susan" è un libro piacevolissimo e curioso, che si legge davvero con piacere.
Temevo di trovare pesante la lettura di Jane Austen, ma non è stato affatto così. "Lady Susan" è un libro piacevolissimo e curioso, che si legge davvero con piacere.